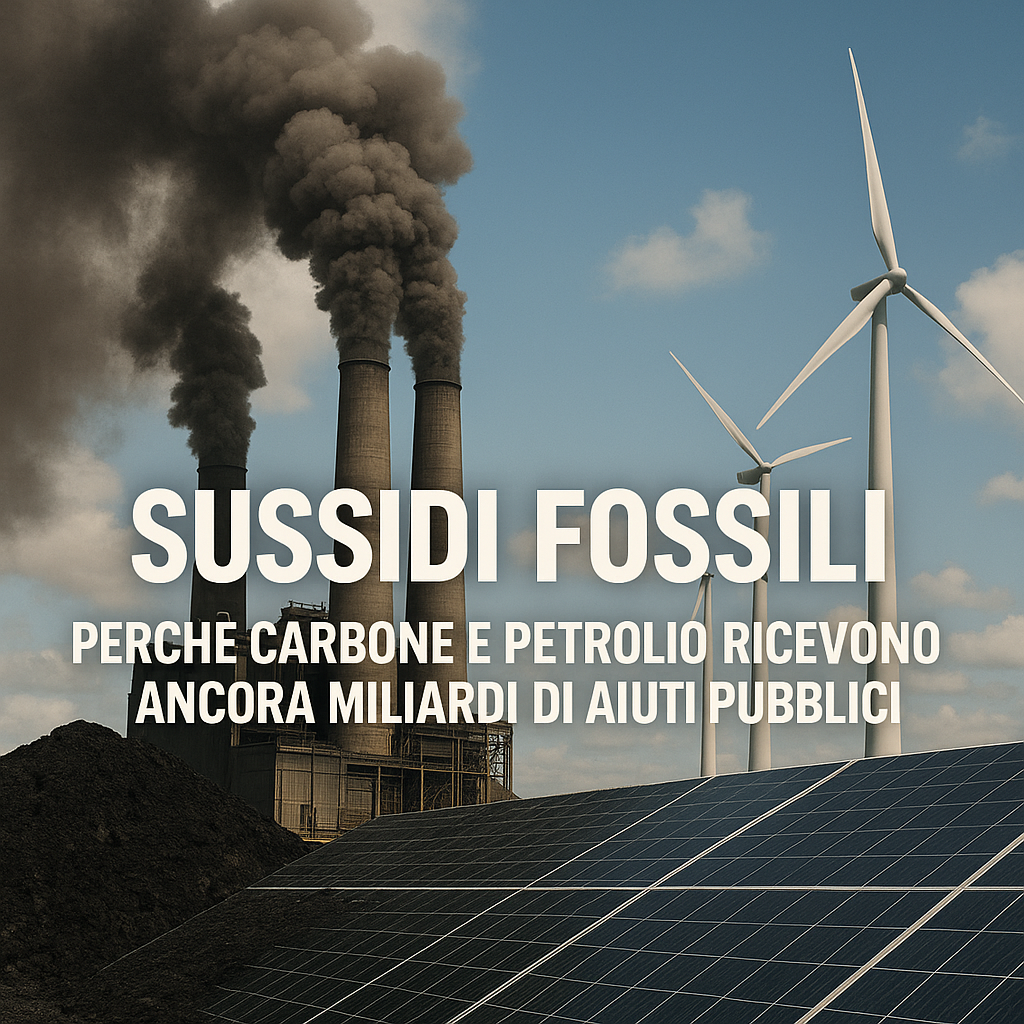
Immagina la scena: stai sorseggiando un bicchiere d’acqua fresca in cucina, magari accendendo il gas per preparare un piatto veloce. Tutto sembra normale, ma quel gesto quotidiano nasconde una verità scomoda: una parte dei soldi che versi nelle bollette viene utilizzata per finanziare la produzione di carbone, petrolio e gas, invece che per promuovere fonti pulite. È una realtà poco visibile, ma persistente. I sussidi alle energie fossili restano saldi, nonostante l’urgenza climatica e le promesse politiche.
I sussidi alle fonti fossili esistono da decenni. I governi li hanno introdotti per motivi economici e sociali: assicurare energia a basso costo alle famiglie, sostenere l’industria nazionale e stabilizzare i mercati in tempi di crisi. Un approccio che poteva avere un senso nel dopoguerra o durante le crisi petrolifere del Novecento. Ma oggi il contesto è cambiato.
Il problema è che queste agevolazioni non solo mantengono artificialmente bassi i costi di carbone, petrolio e gas, ma distorcono il mercato, penalizzando lo sviluppo delle fonti rinnovabili e mantenendo alti i livelli di inquinamento. Il risultato è che la tanto citata transizione energetica rimane rallentata, mentre le emissioni di gas serra crescono.
I numeri impressionano. Nel 2023 i sussidi alle fonti fossili hanno superato 1,5 trilioni di dollari a livello globale. Una cifra enorme se si pensa che è quasi dieci volte superiore agli incentivi destinati alle energie rinnovabili nello stesso anno.
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, se si considerano anche i “sussidi impliciti” – cioè i costi ambientali e sanitari non conteggiati nelle bollette ma pagati dalla collettività – il totale arriva a circa 7 trilioni di dollari, pari a quasi il 7% del PIL mondiale. È come se ogni cittadino del pianeta, anche chi vive in zone senza energia elettrica, contribuisse a finanziare il sistema fossile.
Un esempio molto concreto riguarda i trasporti. In molti Paesi, il gasolio per l’agricoltura e per i camion gode di forti agevolazioni fiscali. Questo fa sì che i prodotti nei supermercati arrivino sugli scaffali a prezzi più bassi, ma al costo di maggiori emissioni e inquinamento atmosferico.
Oppure pensiamo alle bollette del gas: spesso una parte del prezzo viene tenuta bassa grazie a fondi pubblici, rendendo più conveniente cucinare o riscaldare con fonti fossili piuttosto che investire in pompe di calore o altre soluzioni pulite.
In Italia, il caso più discusso è quello delle agevolazioni sul gasolio agricolo e per il trasporto merci, che valgono miliardi di euro ogni anno. In Germania, ancora fino a pochi anni fa, erano presenti aiuti diretti all’estrazione della lignite, uno dei combustibili più inquinanti. Negli Stati Uniti, l’industria del petrolio beneficia da decenni di crediti d’imposta e agevolazioni per nuove trivellazioni.
Questi esempi mostrano come il sostegno pubblico ai fossili non sia un’eccezione, ma una pratica diffusa a livello globale.
Il danno non è solo per il clima. Bruciare combustibili fossili significa anche respirare polveri sottili, ossidi di azoto e altre sostanze che compromettono la salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che milioni di morti premature ogni anno siano legate all’inquinamento atmosferico.
Inoltre, il consumo di combustibili fossili incide anche sull’uso di acqua: le centrali a carbone e a gas richiedono enormi quantità di acqua per il raffreddamento, contribuendo a stress idrico in molte regioni.
Se quei sussidi venissero spostati verso le energie pulite, avremmo un doppio beneficio: ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.
La risposta ha molto a che fare con la politica. Le lobby del petrolio, del carbone e del gas hanno un peso enorme nel dibattito pubblico. Investono in comunicazione, fanno pressione sui governi, e spesso promuovono la narrativa che eliminare i sussidi significherebbe costi insostenibili per famiglie e imprese.
C’è poi la paura sociale: alzare improvvisamente i prezzi dell’energia può generare malcontento e proteste. Non a caso, ogni volta che i governi provano a ridurre i sussidi, il timore di conseguenze politiche immediate frena le riforme.
Sì, e con risultati positivi. L’India, ad esempio, tra il 2014 e il 2017 ha ridotto drasticamente le agevolazioni per petrolio e gas, spostando risorse verso programmi di elettrificazione rurale e incentivi per il solare. In pochi anni milioni di famiglie hanno avuto accesso a energia pulita e più sicura.
Anche la Danimarca e la Svezia hanno ridotto i sussidi, sostituendoli con investimenti in rinnovabili e tecnologie di efficienza energetica, creando allo stesso tempo nuovi posti di lavoro.
Gli esperti propongono una strategia graduale. Eliminare i sussidi più dannosi e allo stesso tempo usare i risparmi per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, ad esempio attraverso trasferimenti diretti di denaro o riduzioni fiscali mirate.
Una parte consistente potrebbe essere investita nella ricerca e nello sviluppo di energie rinnovabili e in nuove soluzioni come l’idrogeno verde o le batterie a lunga durata. In questo modo, il sistema diventerebbe più resiliente e meno dipendente da risorse inquinanti e instabili.
Molti Paesi del G20 hanno promesso di eliminare i sussidi fossili “inefficienti” entro il 2025. Il Parlamento Europeo ha chiesto una data precisa e vincolante, ma nei fatti gli Stati continuano a rimandare.
All’ONU, diversi esperti hanno definito immorale continuare a finanziare le fonti fossili con denaro pubblico, parlando di una vera e propria contraddizione rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.
Se le promesse verranno mantenute, nei prossimi anni vedremo una progressiva riduzione dei sussidi più evidenti, ma è probabile che alcuni sopravvivano più a lungo. La sfida sarà politica e culturale: bisognerà spiegare che eliminare i sussidi non significa abbandonare i cittadini, ma sostituire un aiuto dannoso con uno che porta benefici concreti e duraturi.
Tutto torna al gesto iniziale. Quel fornello che accendi o quella benzina che metti nel serbatoio sono parte di un sistema più grande. Finché il denaro pubblico continuerà a sostenere le fonti fossili, continueremo a respirare aria inquinata e a pagare indirettamente i danni del cambiamento climatico.
Ma se quelle stesse risorse venissero spostate su energie pulite, ogni euro speso diventerebbe un investimento per ridurre le emissioni, migliorare la qualità dell’aria, proteggere l’acqua e rendere le nostre città più vivibili.
La storia dei sussidi fossili è, in fondo, la storia di come scegliamo di usare i nostri soldi comuni. E dipende da noi e dalla politica decidere se continuare a finanziare il passato o costruire un futuro più giusto e sostenibile.
Fonti