
La Commissione Europea ha pubblicato la 2025 Environmental Implementation Review dedicata all’Italia, un bilancio periodico che misura quanto il nostro Paese stia applicando le norme ambientali europee e quali passi restino da compiere. È un’istantanea utile non solo per gli addetti ai lavori: racconta se l’Italia sta davvero riducendo inquinamento, consumi di risorse e perdita di biodiversità, e quanto è preparata a rispettare gli obiettivi fissati per il 2030 e il 2050. Il messaggio di fondo è chiaro: attuare bene le regole ambientali non è un orpello burocratico ma un fattore di competitività, salute pubblica e sicurezza economica, perché riduce i danni da eventi estremi, rende più efficiente l’uso dell’acqua e spinge innovazione e occupazione nella clean tech.
La Environmental Implementation Review è un pacchetto che comprende una comunicazione generale sull’andamento nell’Unione e un rapporto per ciascuno Stato membro con le azioni prioritarie. Non è una sanzione, né un ranking di merito, ma una bussola per amministrazioni, imprese e cittadini. Indica dove l’Italia procede bene e dove rallenta, suggerendo interventi concreti e indicando, quando possibile, le fonti di finanziamento europee più adatte. È anche un promemoria sul nuovo contesto normativo: nel 2025 sono stati aggiornati pilastri come la direttiva Aria e la direttiva Acque reflue urbane, mentre è entrata nella fase attuativa la Nature Restoration. Il senso è semplice: servono tempi certi, dati trasparenti, capacità amministrativa e investimenti mirati per chiudere il divario tra obiettivi e realtà.
Nel quadro europeo, la Commissione registra un miglioramento di lungo periodo nella qualità dell’aria, una crescita della quota di materiali reimmessi in ciclo e un ampliamento delle aree protette. L’Italia parte da una posizione particolare: un tessuto industriale che innova più di quanto si pensi, piccole e medie imprese abituate a ridurre scarti e materie prime, distretti dove l’economia circolare è pratica quotidiana. Questo patrimonio si traduce in buone performance su alcuni flussi di rifiuti, nella diffusione della raccolta differenziata e nella capacità di recupero di materia in tante filiere. Sul fronte natura, la rete Natura 2000 è ampia e consolidata, e il potenziale di ripristino ecologico è alto se accompagnato da regole chiare, coinvolgimento degli operatori e risorse adeguate.
Il cuore del dossier sono le azioni prioritarie. Per i rifiuti il richiamo è a ridurre in modo stabile lo smaltimento in discarica e a spostare più frazioni verso prevenzione, riuso e riciclo, con particolare attenzione a raccolta alla fonte, infrastrutture per il bio-waste e aumento delle capacità di trattamento nelle aree in ritardo. La Commissione invita a estendere in modo credibile i meccanismi di tariffazione puntuale, a rafforzare i sistemi di responsabilità estesa del produttore e a migliorare la qualità dei dati sugli imballaggi per rendere verificabili gli obiettivi. Nel quadro dei nuovi obblighi europei, viene indicata anche la necessità di sistemi che aumentino il ritorno effettivo dei contenitori e migliorino la resa del riciclo.
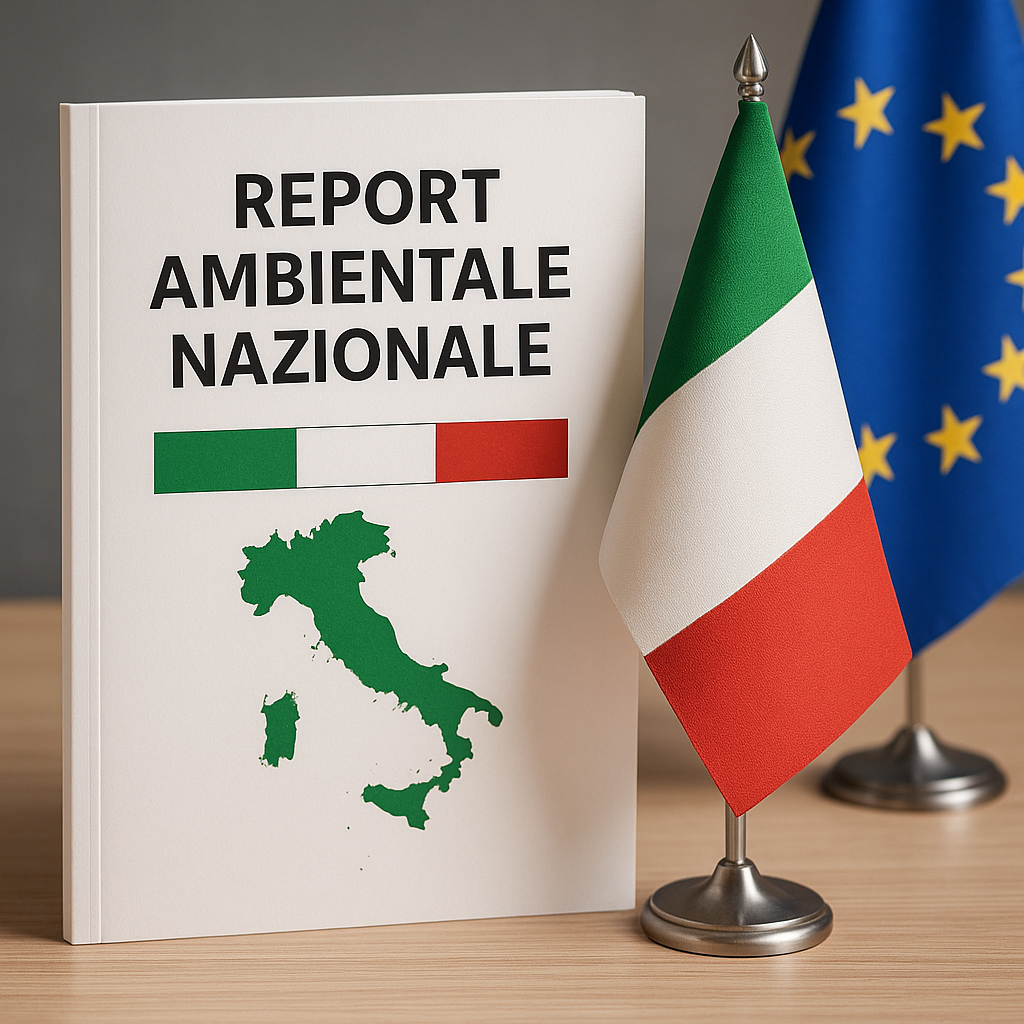
Sull’acqua la priorità è duplice. Da un lato occorre chiudere definitivamente il contenzioso storico sull’adeguamento dei depuratori e portare a conformità tutti gli agglomerati urbani, anche in vista dei requisiti più stringenti della direttiva aggiornata. Dall’altro va aggredita l’inquinamento da nutrienti legato all’agricoltura, con piani nitrati efficaci, controlli coerenti e misure agroambientali mirate. La Commissione insiste inoltre sul miglioramento del monitoraggio, sulla corretta classificazione dei corpi idrici e sull’uso diffuso di soluzioni basate sulla natura per restituire funzionalità ai corsi d’acqua e aumentare la resilienza idrologica.
Per la qualità dell’aria il dossier chiede che il Piano nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico diventi più incisivo, riducendo le emissioni dei principali inquinanti e assicurando il rispetto dei limiti aggiornati. Al tema si lega l’efficienza della rete di monitoraggio, che deve garantire dati completi e puntuali nelle aree critiche, dalle città alla Pianura Padana. Le misure strutturali richieste includono interventi su riscaldamento civile poco efficiente, traffico e agricoltura intensiva, con approcci integrati regionali e urbani.
Sul versante industriale emerge un’indicazione molto concreta che riguarda l’ex-ILVA di Taranto: la Commissione chiede di contenere l’inquinamento idrico e riportare l’impianto in piena conformità con la normativa sulle emissioni industriali, recependo e applicando le migliori tecniche disponibili e assicurando un controllo efficace. È un caso simbolico perché intreccia tutela ambientale, salute pubblica e continuità produttiva, e rende evidente come la qualità dell’attuazione sia decisiva quanto la norma.
Per natura e biodiversità l’Italia è chiamata a completare e rendere operative le misure di conservazione nei siti Natura 2000, a integrare la tutela della biodiversità nella pianificazione agricola, energetica e delle infrastrutture e a ridurre i carichi di azoto nelle aree più sensibili. La spinta è a passare dalla sola designazione alla gestione efficace, con obiettivi misurabili, monitoraggi adeguati e un finanziamento stabile, incluse le opportunità dei Programmi di Sviluppo Rurale e dei fondi LIFE.
La Commissione parla esplicitamente di divario di implementazione e di investimenti. Per l’Italia questo significa due cose. Primo, servono più risorse nazionali dedicate, insieme a fondi europei e capitali privati, per colmare i ritardi infrastrutturali in acqua, rifiuti e aria e per sostenere il ripristino degli ecosistemi. Secondo, vanno semplificate le procedure senza abbassare l’asticella ambientale, con dati aperti e facilmente accessibili, valutazioni ambientali trasparenti, tempi certi e un migliore accesso alla giustizia in materia ambientale. Questi elementi non sono dettagli tecnici: riducono il rischio percepito dai finanziatori e accelerano i cantieri che migliorano la qualità della vita.
C’è poi un tema di capacità amministrativa. Molte misure falliscono non per assenza di norme ma per carenza di personale formato, banche dati non interoperabili, monitoraggi frammentati. La spinta della Review è creare una catena del valore dell’attuazione: programmazione credibile, progetti bancabili, gare veloci, controlli efficaci, indicatori che misurano risultati. È la condizione perché l’Italia possa utilizzare al meglio PNRR residuale, fondi di coesione, strumenti BEI e risorse nazionali verdi, orientando ogni euro a risultati misurabili.
Tradurre la Review in azione significa avere città con aria più pulita, meno giornate di sforamento e meno costi sanitari. Significa fiumi e coste con acque più sicure, meno perdite nelle reti e impianti di depurazione affidabili. Significa ridurre le discariche e valorizzare materia secondaria che oggi perdiamo, con filiere di riciclo che creano occupazione e riducono importazioni di materie prime. Significa proteggere ecosistemi che sostengono agricoltura, turismo e difesa dal rischio idrogeologico. Per le imprese, regole applicate bene e in modo omogeneo in tutto il Paese riducono incertezza regolatoria e costi, e aprono mercati per tecnologie e servizi ambientali italiani già competitivi in Europa.
Il percorso realistico parte dai nodi più noti. Chiusura dei procedimenti aperti su acque reflue urbane con un piano operativo che agganci le nuove soglie della direttiva aggiornata. Un programma nitrati che riduca davvero i carichi di nutrienti, con controlli seri e sostegno economico a pratiche efficienti. Una strategia aria che metta insieme Regioni e grandi aree urbane e intervenga su riscaldamento, trasporti e agricoltura con strumenti economici e tecnologie mature. Per i rifiuti, investimenti nella raccolta di qualità e nel trattamento del bio-waste, migliorando i sistemi di responsabilità dei produttori e la tracciabilità degli imballaggi. Per Natura 2000, piani di gestione operativi e finanziati, in sinergia con agricoltura e pianificazione energetica. Sul fronte industriale, applicazione piena delle migliori tecniche disponibili e completamento dei piani di adeguamento nei siti più complessi, con trasparenza dei dati verso i cittadini.
La Environmental Implementation Review 2025 è una chiamata a fare sul serio. L’Italia ha competenze, aziende e territori in grado di guidare la transizione ecologica. Servono continuità, governance moderna e investimenti selettivi là dove l’impatto è maggiore: aria nelle aree più critiche, acqua e depurazione nei comuni in ritardo, gestione dei rifiuti nel Mezzogiorno, ripristino della biodiversità dove garantisce servizi ecosistemici strategici. È una partita non ideologica ma concreta, che lega salute, ambiente, filiere produttive e finanza pubblica. Attuare bene le regole europee è il modo più rapido e meno costoso per migliorare la qualità della vita e rafforzare la competitività del Paese.
FontiCommissione Europea – Comunicazione EIR 2025: https://environment.ec.europa.eu/document/download/05a3b495-14b1-4e21-b12f-e90750a486ed_en?filename=COM_2025_420_F1_COMMUNICATION_FROM_COMMISSION_TO_INST_EN_V6_P1_4037868.PDFCommissione Europea – EIR 2025 Allegato con azioni prioritarie: https://environment.ec.europa.eu/document/download/c647baaf-02fc-4546-a9d3-d659fb5ab631_en?filename=COM_2025_420_F1_ANNEX_EN_V3_P1_4136108_0.PDF